Una storia al contrario di Francesca De Sanctis è un invito
ad aggrapparsi con coraggio alla cultura.
Un romanzo autobiografico dedicato alla fine dell’Unità,
in cui l’introspezione si fonde con il gesto politico
Testo Sofia Chiappini
Riconnettersi con pazienza e dedizione con se stessi, evitando l’immobilismo: questo è l’autoritratto che ricaviamo dal libro di Francesca De Sanctis. Giornalista freelance, collabora oggi con diverse testate nazionali, ma la sua è Una storia al contrario, che ha inizio in tutt’altro modo. Entrata a far parte dell’Unità giovanissima, diventa qui, appena sei anni dopo, vice-caposervizio delle pagine nazionali di cultura e spettacoli, portando avanti l’attività di critico e, tra le altre, quella di direttrice artistica del Festival di teatro civile della sua città natale, il CassinoOFF. Ma, improvvisamente (o quasi), qualcosa cambia.
Francesca De Sanctis non è una donna dalle ricette immediate o semplicistiche, proprio per questo il suo libro rappresenta un valido tramite per confrontarsi con il sentimento di fallimento e con tutte quelle emozioni riguardanti la fine di certi aspetti centrali nella nostra vita. In questo caso si chiama in causa principalmente (ma non solo) la sfera lavorativa, a seguito della chiusura dell’Unità.
«Scrivere questo libro è stato per me un modo di elaborare un lutto, per questo ho deciso di parlare di tanti aspetti della mia vita privata di cui non avevo mai scritto prima. Del rapporto con mio padre, ad esempio, ma anche della morte, della mia malattia e del trauma della fine dell’Unità».
A novant’anni dalla sua fondazione, ad opera di Gramsci, l’Unità subisce il tracollo economico. Il fallimento è, come leggiamo nel suo libro, morale, politico e sociale. Le forze politiche in gioco e, in modo particolare quelle del PD, decidono di non schierarsi in favore di un salvataggio della testata. Nel suo libro sono raccontate, seppur quasi mai in ordine cronologico, le alterne vicende che hanno caratterizzato il lento e doloroso declino del celebre quotidiano, fino alla fine del periodo di cassa integrazione per i dipendenti nel 2019. La scelta di non riportare quanto accaduto secondo una narrazione lineare del tempo, in un intreccio tra vita lavorativa e vicende personali, ci permette di figurarci senza difficoltà il marasma caotico che ha coinvolto gli impiegati dell’Unità.
La garanzia di un welfare democraticamente accessibile a tutti è stato uno dei modelli trainanti, all’interno della concezione socio-economica dell’Europa continentale. Assai diverso e, per certi versi opposto, è invece il modello verso il quale il mondo del lavoro si sta, da diverso tempo ormai, orientando. In questo senso, ad essersi imposta più di tutte è l’idea secondo cui sarebbe l’interesse privato a dover prevalere sull’idea di benessere generalizzato, una prospettiva di cui, oggi più che mai, percepiamo gli effetti. Il fallimento di alcune aziende non è più evitato, in
virtù del loro valore economico e sociale, attraverso interventi statali; vendite e cessioni del personale sono sempre più frequenti, come anche i licenziamenti a seguito di tali eventi.
Il sentire comune sembra concordare ormai con quella concezione che vorrebbe vedere la crisi come qualcosa di endemico. Convinzione molto spesso avvalorata da un situazione senza vie di uscita immediate, che ci induce con una certa spontaneità a credere che sia effettivamente questo l’unico futuro possibile e, forse, persino auspicabile. La crisi è naturale: lo hanno affermato in passato l’economia e la psicologia, lo ripete oggi a gran voce la storia. Eppure, nonostante tutto, risulta difficile credere che qualcuno possa davvero sentirsi a proprio agio in una così grave
situazione d’incertezza o che la maggioranza possa assistere, con consapevole serenità, alla fine caotica di un mondo.
«Il caos che racconto
ci riguarda da vicino,
come la stessa
pandemia, che piomba
verso la parte finale del
libro, e che riguarda un
po’ tutti noi».
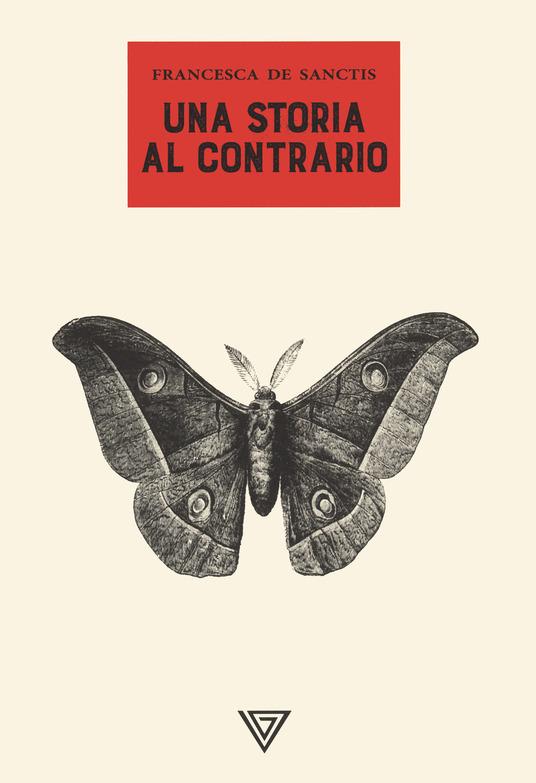
Un esodo in cui ad essere allontanata è la nostra identità, ormai allo sbando. Una perdita identitaria che alcuni partiti o personaggi pubblici utilizzano, con fin troppa facilità, come arma di ricatto psicologica ed elettorale. Una situazione di grande complessità in cui, però, siamo soltanto noi, alla fine dei giochi, a doverci confrontare con domande scomode e di difficile risoluzione, e di cui Francesca De Sanctis nel suo libro ci fornisce delle prove concrete e quanto mai commoventi. Anche qui, non ci è offerta nessuna “ricetta”, bensì con lucida onestà sono raccontati i problemi, ad esempio familiari o economici, al riparo da qualsiasi retorica.
Eppure, persino in questo contesto di disastrosa dissoluzione della normalità, l’autrice ci viene incontro con una prospettiva, se vogliamo, più alta ma non per questo meno accessibile, in cui è, anzi, proprio il sentimento di solitudine e la profonda accettazione di quest’ultimo a darci conforto e sollievo. A proposito di questo e in riferimento alla parte finale del libro, mi racconta della sua abitudine, nel periodo di confinamento forzato di quei mesi del 2020, di affacciarsi alla finestra, «per vedere la vita a un’altezza diversa della città». Attraverso la sua narrazione quello che vediamo è, certamente, un mondo al contrario, in cui a prevalere è un’ingiusta marginalità dell’impegno contratto nei
confronti della cultura; accompagnato, tuttavia, da un sano bisogno di evasione, in cui è l’immaginazione a prendere corpo dietro una tenda svolazzante o una finestra dischiusa. In quella Roma ritratta nelle sue stanze «la vita non si è svolta più al piano terra, ma lo ha fatto ai piani alti dei condomini e dei terrazzi», quasi per compensare il bisogno irrefrenabile dei moltissimi che, come Francesca De Sanctis, non potrebbero concepire la propria vita senza un palchetto, una poltrona o una scomoda sedia da cui sbirciare lo scorrere inesorabile di vite altrui.



